Con un deficit attuale stimato in 380 milioni di dollari ed un debito pubblico accumulato negli anni ed oscillante tra i 18 ed i 20 miliardi di dollari, Detroit è la prima grande metropoli americana a dichiarare fallimento. La municipalità cittadina, stretta tra i veti incrociati dei creditori da una parte (oltre 100.000, in primis alcuni importanti fondi pensione) e gli irremovibili no dei sindacati dei dipendenti pubblici ad ogni concessione dall’altra, si è trovata infine costretta dalla mancanza di una mediazione ragionevole a ricorrere al “Chapter 11” (una procedura molto simile al concordato preventivo previsto dalla Legge Fallimentare italiana).
Il “peccato originale” sta, secondo i principali analisti finanziari ma anche alla luce delle più neutrali statistiche, in un settore pubblico divenuto nel tempo elefantiaco. Con 13.000 lavoratori in organico all’amministrazione cittadina, Detroit è giunta al rapporto record di 1 dipendente pubblico ogni 55 abitanti: decisamente troppo, tanto più nella terra dello Stato “leggero”.
Alla extrema ratio della bancarotta si sono infine decisi, giovedì pomeriggio del 18 luglio, il governatore repubblicano del Michigan Rick Snyder ed il commissario straordinario Kevin Orr, l’emergency manager chiamato quattro mesi prima a tentare un’ultima mediazione tra le parti in causa, poi rivelatasi impossibile da raggiungere. “Reinventing Detroit”: questo lo slogan che campeggiava alle spalle dei due durante la conferenza stampa dell’annuncio, mentre le parole di Orr dipingevano uno scenario fosco e, purtroppo, non irreale: “Vi sembra possibile vivere in una città dove i bambini camminano lungo strade buie e malmesse, dove sui tetti delle case fatiscenti crescono arbusti o dove, se chiamate la polizia, gli agenti arrivano dopo un’ora perché sono pochi?”.
Ed in effetti Detroit appare, e non da oggi, una città tutta da reinventare. La sua storia “recente” ci parla di un declino lungo almeno 50 anni, che ha condotto – inesorabilmente, giorno dopo giorno – quella che era stata l’illustre e gloriosa capitale americana (e mondiale) dell’industria automobilistica made in USA (General Motors, Ford, Chrysler) ad inanellare una serie di primati negativi: capitale della disoccupazione, capitale della povertà e capitale del crimine (non è un caso che un film cult degli anni ’80 come Robocop sia ambientato proprio in una Detroit degradata ed in mano alla violenza anarchica delle gang cittadine, non troppo dissimile dalla realtà).
I numeri parlano chiaro e non sembrerebbero affatto consoni non solo a quelli della prima superpotenza mondiale, ma in generale a scenari nordamericani.
In primo luogo, l’aspetto più sconvolgente è senza dubbio il tracollo demografico. Alla fine degli anni ’50 Detroit, all’apice di quel trionfo industriale che trascinava in avanti una buona fetta del Pil americano, contava oltre 1.800.000 abitanti ed era la quarta metropoli USA. Oggi gli abitanti della città, già campionessa del Midwest assieme a Chicago, sono meno della metà, circa 680.000.
La superficie della città (pari a quella di San Francisco, Boston e dell’isola di Manhattan messe assieme, dove però vivono quasi 3 milioni di persone) è rimasta quella di allora: ma nel frattempo tantissime zone si sono spopolate a seguito della grande emigrazione, in particolare nelle zone del centro, ed ora appaiono simili ad enormi “quartieri fantasma”, ombra pallida e lontana di quello che furono un tempo. Grandi spazi verdi sono cresciuti al suo interno a dismisura, e non si tratta di giardini e parchi curati, ma di sterpaglie ed arbusti: un verde incolto, disordinato ed abbandonato dall’opera dell’uomo.
Anche la qualità del tessuto urbano e, in generale, del tenore di vita è grandemente peggiorata, lasciando dell’“american way of life” uno sbiadito ricordo nella grande maggioranza dei cittadini residenti. Queste le cifre della decadenza: più di 78.000 gli edifici interamente abbandonati, altre decine di migliaia quelli sottopopolati (tra cui importanti grattacieli cittadini, simbolo di quell’America “rampante” che qui ha perso la propria spinta propulsiva) e necessitanti di interventi di restauro che difficilmente arriveranno. Il 40% delle luci della rete di illuminazione pubblica non è funzionante. Numerose scuole ed ospedali sono stati chiusi o lo saranno a breve, mentre già ora solo 1/3 del parco ambulanze è in funzione. Migliaia di uffici e negozi hanno chiuso battenti ed il mercato degli affitti (come in genere l’intero settore immobiliare) solo da due anni a questa parte conosce una piccola ripresa. Infine le ampie arterie stradali, costruite ai tempi del boom, appaiono oggi semivuote: e non c’è forse più grande paradosso in quella che tuttora resta – sia pur ampiamente depotenziata – la capitale americana (e non più mondiale) dell’automobile!
Di questi 680.000 abitanti rimasti in una metropoli immensa e spopolata, il 26% vive sotto la soglia di povertà, laddove la media USA è di circa il 13%. Spaventoso il dato riguardante i bambini, addirittura il 60% dei quali si trova sotto tale soglia. Le statistiche rivelano poi che il 20% della popolazione attiva residente è disoccupata: dato che – per quanto in miglioramento, grazie alla recente ripresa del settore auto, rispetto al 25% toccato all’apice della crisi – rimane anch’esso largamente superiore alla media nazionale ferma all’8%. Sconvolgente il dato sugli analfabeti, che sono il 50% della popolazione. Percentuali che nessuno si poteva immaginare riferite ad una città degli Stati Uniti d’America. Particolare non trascurabile: Detroit è città afroamericana all’82%…
Poco lontano, oltre il confine, le ricche ed efficienti città canadesi (con la grande Toronto sullo sfondo) fanno sfigurare, sotto ogni punto di vista, la loro vicina povera statunitense…
Come si è potuti arrivare a questo?
Secondo uno studio dell’Aia – l’associazione americana degli architetti e degli urbanisti, per i quali Detroit è diventata una vera e propria case history – l’origine dei mali sarebbe da rintracciarsi nella prima metà degli anni ’60. Allora iniziò lo spostamento della popolazione bianca (già allora minoranza, seppur più consistente di oggi) fuori città o verso i suoi sobborghi cittadini più ricchi, dove peraltro c’erano – e ci sono tutt’ora – il grosso degli stabilimenti industriali. L’emigrazione di gran parte della middle class bianca verso le periferie ha causato la chiusura e l’abbandono di uffici e negozi del centro. La popolazione rimasta era più povera e più dipendente da quegli stessi servizi pubblici che la municipalità, impoverita da entrate fiscali in costante diminuzione, era sempre meno in grado di fornire. I violenti scontri razziali del 1967 finirono per trasformare l’emigrazione dei bianchi in un esodo che – come già si era visto, sia pur in misura meno drammatica – aggravò l’impoverimento della città nel suo complesso, a causa della riduzione dei redditi tassabili, avviando un circolo vizioso: il comune aveva sempre minori fondi per mantenere in efficienza i servizi pubblici, il cui peggioramento ha reso Detroit sempre meno accogliente, non facendo nulla per limitare l’emigrazione (ormai non più limitata ai soli bianchi), ma anzi favorendola sempre di più. Ma c’è dell’altro.
A fine anni ’70-inizio anni ’80 la “rivoluzione neoliberista” avviata dalla Thatcher in Gran Bretagna e da Reagan negli Stati Uniti trova in una Detroit già in difficoltà il terreno ideale per i suoi esperimenti economici. L’onda lunga della nuova dottrina, impostata sul ruolo dominante della finanza rispetto a quello – considerato sussidiario – dell’economia reale, favorì la deindustrializzazione e la delocalizzazione degli impianti manifatturieri e produttivi nei Paesi in via di sviluppo per ridurre i costi del lavoro. Detroit, che aveva fatto della produzione la propria ragion d’essere, viene colpita durissimamente. Iniziano a chiudere i battenti numerosissimi stabilimenti dei tre giganti dell’auto, Ford, General Motors e Chrysler, determinando la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. La sconfitta dei potenti sindacati statunitensi dei metalmeccanici, siderurgici ed operai dell’industria automobilistica (al pari della contemporanea debacle dei minatori inglesi) per mano delle grandi lobbies finanziarie e dei loro esponenti allora ai vertici politici di Stati Uniti e Gran Bretagna segna realmente la fine di un’era nella storia economica dell’Occidente. Di fatto, nella fattispecie, era anche la condanna a morte di una grande città industriale come Detroit, che aveva fatto della manifattura e del “duro lavoro” operaio il perno del proprio sviluppo fin dal XIX secolo.
L’industria automobilistica non muore del tutto, ma col tempo viene ridotta al lumicino. I numeri parlano chiaro: alla fine degli anni Cinquanta, a Detroit, i dipendenti di Ford, General Motors e Chrysler superano, compreso l’indotto, le 200.000 unità. I dipendenti dello stesso settore oggi, nel 2013, sono 20.000: un decimo rispetto ad allora. Sono 3.000 i dipendenti della sede centrale della GM, l’unica ancora a Detroit, mentre sono 4.633 i dipendenti della fabbrica Chrysler in città, con la nuova gestione Fiat che vi ha assegnato l’assemblaggio della nuova Jeep Grand Cherokee.
Ancora tra il 2000 ed il 2010, il 48% dei posti di lavoro perduti nello Stato del Michigan era nel ramo manifatturiero. L’inversione di tendenza è cominciata solo sotto la presidenza Obama, che ha fatto della difesa della classe operaia statunitense e del salvataggio (riuscito) dell’industria automobilistica nazionale uno dei cavalli di battaglia della propria amministrazione: una vittoria che gli è valsa la rielezione alle presidenziali del 2012.
Ed ora?
Il presente ed il futuro prossimo di Detroit appaiono segnati da un dualismo politico ed economico.
Per quanto riguarda il primo, esso si manifesta tra lo Stato del Michigan da una parte, repubblicano e a maggioranza bianca, il cui governatore Snyder è stato favorevole alla proclamazione della bancarotta, e la città di Detroit dall’altra, democratica ed afroamericana. Obama, che riscuote di larghissimo consenso nella principale città del Michigan, non potrà probabilmente fare molto per aiutarla: non solo i vertici di quello Stato sono in mano ai repubblicani, ma anche la Camera dei Rappresentanti lo è e così pure la Corte Suprema vede al momento una maggioranza di esponenti conservatori, riducendosi in tal modo di molto il suo margine di manovra.
Nel secondo caso, invece, appare clamoroso il fatto che, mentre la municipalità dichiara il fallimento, l’industria dell’auto negli ultimi due anni è in forte ripresa e fa ripartire investimenti e consumi, portando nuova occupazione e vita in una città che sembrava condannata ad un declino inesorabile. E se c’è già chi vede in questo l’ennesima conferma che “il privato è buono e il pubblico è cattivo”, non manca d’altra parte chi sottolinea che si tratta di due pesi e due misure.
Quando, infatti, quattro anni fa erano General Motors e Chrysler sull’orlo del baratro e scattò per loro il “Chapter 11”, la stessa procedura di bancarotta ora avviata per Detroit, furono sì chiesti pesanti sacrifici ai lavoratori (licenziamenti e dimezzamento dei salari per i nuovi assunti), ma al tempo stesso lo Stato intervenne con decine di miliardi di dollari a sostenere quelle aziende che, pur private, rappresentano nel mondo l’industria dell’auto made in USA.
Detroit, invece, ha la “colpa” di rappresentare solo sé stessa. E nel suo caso ci saranno solo i sacrifici senza gli aiuti. Si parla già di licenziamenti di alcune migliaia dei 13.000 dipendenti pubblici – mentre i restanti si vedranno tagliare i salari – con le inevitabili ricadute che questo comporterà nei servizi ai cittadini, già ridotti all’osso. È il paradosso del neoliberismo americano, in cui si chiude un occhio sulle “spericolatezze finanziarie” del grande settore privato che, quando poi si ritrova vicino al collasso, viene salvato coi soldi pubblici dietro il ricatto che una sua caduta comporterebbe il tracollo dell’intera economia. Mentre poi, quando l’economia si riprende, è lo Stato a rimanere povero ed indebitato. Fino al “giro” successivo.
Ma nonostante ciò, come sempre dopo ogni tabula rasa, c’è chi si sforza di vedere, una volta toccato il fondo del baratro, le basi per una nuova ripartenza. Le ferite sociali si annunciano già dolorose, e per ora lo shock è fortissimo ed ha scosso gli interi Stati Uniti. Ma si spera che la ripresa dell’industria automobilistica prosegua la sua corsa e finisca per trainare una seconda volta a nuovo splendore una Detroit che, nonostante tutto, non si rassegna a fare la parte della Grecia d’America.




















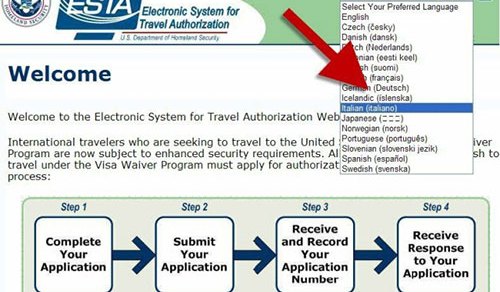
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento