
Riconosciuto fra i più importanti esperti a livello nazionale dei temi di responsabilità civile (applicati ad internet, all’impresa e soprattutto alla famiglia) al prof. Giuseppe Cassano è stato chiesto di discutere e di approfondire i temi della esecuzione dei provvedimenti di diritto di famiglia, non ultima la complessa situazione derivante dalla cd PAS (sindrome di alienazione parentale).
Attualmente sui media nazionali vi è una campagna pubblicitaria che sempre più discute di questa complessa questione, e quindi si è cercato nella relazione di fare il punto alla luce delle eventuali ricadute sull’assetto della responsabilità civile e del diritto di famiglia.
La sindrome da alienazione genitoriale (o PAS, dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome) è una ipotetica e controversa dinamica psicologica disfunzionale che, secondo le teorie dello psichiatra statunitense Richard Gardner, si attiverebbe sui figli minori coinvolti in contesti di separazione e divorzio conflittuale dei genitori, non adeguatamente mediate. La PAS è oggetto di dibattito ed esame ― sia in ambito scientifico sia giuridico ― fin dal momento della sua proposizione nel 1984; essa non è, infatti, riconosciuta come un disturbo psicopatologico dalla grande maggioranza della comunità scientifica e legale internazionale.
Cassano infatti ha fatto notare come sono da evitare facili generalizzazioni e che i progetti di legge debbano prevedere sanzioni alle eventuali strumentalizzazioni che se ne possano generare, come ad es. introdurre problematiche di stalking o di sindrome di alienazione parentale finalizzate ad aumentare il proprio potere “contrattuale ” o “ricattatorio” in fase di affidamento dei figli.
Le tecniche di «programmazione» del genitore «alienante» comprenderebbero l’uso di espressioni denigratorie riferite all’altro genitore, false accuse di trascuratezza nei confronti del figlio, violenza o abuso (nei casi peggiori, anche abuso sessuale), la costruzione di una «realtà virtuale familiare» di terrore e vessazione che genererebbe, nei figli, profondi sentimenti di paura, diffidenza e odio verso il genitore «alienato». I figli, quindi, si alleerebbero con il genitore «sofferente»; si mostrerebbero come contagiati da tale sofferenza e inizierebbero ad appoggiare la visione del genitore «alienante», mostrando ― in modo apparentemente autonomo ― astio, disprezzo e denigrazione verso il genitore «alienato».
Peraltro esistono già dei primi precedenti giurisprudenziali che hanno recepito questa tesi, sottraendo l’affidamento a quel genitore che abusando della propria posizione ha denigrato l’altro ingenerando il rifiuto da parte del minore.


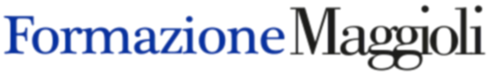


















Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento