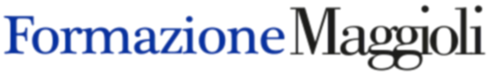Con la circolare n. 125 dell’11 settembre 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sugli obblighi contributivi per ricercatori e post-doc, derivanti dalla stipula dei contratti di ricerca e degli incarichi post-doc, previsti dagli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010. Si tratta di una novità di grande rilievo per il mondo accademico e della ricerca, che interessa università, enti pubblici di ricerca e istituzioni scientifiche, oltre che i giovani studiosi che si affacciano alla carriera accademica.
Il documento definisce in modo puntuale il quadro normativo, specifica la natura dei contratti, le regole di selezione, la durata, il trattamento economico e soprattutto gli aspetti previdenziali e contributivi.
L’INPS chiarisce che per questi rapporti si applicano le stesse regole dei contratti a tempo determinato, con alcune particolarità per la gestione da parte delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la circolare introduce i codici identificativi da utilizzare nei flussi Uniemens per dichiarare correttamente le posizioni dei lavoratori interessati.
Iscriviti al canale Telegram di LeggiOggi per ricevere altre news e aggiornamenti su contributi e lavoro, e alla Newsletter gratuita di LeggiOggi.
Indice
Contratti di ricerca: a chi si rivolgono
I contratti di ricerca, disciplinati dall’art. 22 della legge n. 240/2010, sono rapporti di lavoro a tempo determinato destinati all’esclusivo svolgimento di progetti di ricerca. Introdotti in sostituzione degli assegni di ricerca, possono essere stipulati da università, enti pubblici di ricerca e istituzioni equiparate.
Questa tipologia di contratti:
- ha durata biennale, rinnovabile una sola volta, con limite massimo di cinque anni complessivi (anche presso istituzioni diverse);
- è destinata a candidati con dottorato di ricerca, titolo equivalente conseguito all’estero o specializzazione in area medica;
- prevede una retribuzione non inferiore al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
Non danno diritto all’accesso automatico ai ruoli accademici e non sono compatibili con la frequenza di corsi di studio universitari o con altri rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni, che comportano invece l’aspettativa senza assegni.
Incarichi post-doc
Gli incarichi post-doc sono invece stati introdotti dall’art. 22-bis della legge n. 240/2010. Si tratta di contratti a tempo determinato che si collocano nella fase pre-ruolo della carriera accademica e hanno la finalità di consentire lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione didattica e di “terza missione” (cioè attività di trasferimento tecnologico e di diffusione della conoscenza).
Questi:
- sono riservati a chi possiede un dottorato di ricerca, un titolo equivalente o una specializzazione medica;
- hanno durata annuale, prorogabile fino a un massimo di tre anni complessivi;
- prevedono un trattamento economico minimo stabilito con decreto ministeriale, non inferiore a quello del ricercatore confermato a tempo definito;
- non sono compatibili con altri rapporti di lavoro subordinato e comportano, per i dipendenti pubblici, l’aspettativa senza assegni.
Questa nuova figura si affianca ai contratti di ricerca, ma si caratterizza per una durata più breve e per un inquadramento più specifico nella fase di transizione tra formazione e carriera accademica.
Gli obblighi contributivi per i contratti di ricerca e post-doc
Il punto centrale della circolare riguarda la contribuzione previdenziale. L’INPS chiarisce che sia i contratti di ricerca che gli incarichi post-doc sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Ricercatori e post doc quindi devono fare riferimento alle stesse regole.
Perciò i datori di lavoro sono tenuti a:
- versare i contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) presso le casse e i fondi di riferimento (ad esempio CPDEL, CTPS, CPS, FPLD);
- adempiere agli obblighi relativi al trattamento di fine rapporto (TFR);
- contribuire alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, se previste;
- versare la contribuzione per la NASpI nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile.
Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto per altri contratti a termine. Inoltre, le pubbliche amministrazioni non devono versare contributi per malattia e maternità, poiché in questi casi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Modalità di dichiarazione nei flussi Uniemens
Un aspetto tecnico molto importante riguarda le modalità con cui i datori di lavoro devono dichiarare questi rapporti nei flussi Uniemens. La circolare introduce codici specifici:
- “52” per i contratti di ricerca (art. 22);
- “53” per gli incarichi post-doc (art. 22-bis);
- “63” per l’aspettativa legata ai contratti di ricerca;
- “64” per l’aspettativa legata agli incarichi post-doc.
Questi codici devono essere utilizzati a partire dalla pubblicazione della circolare e servono a garantire una corretta tracciabilità delle posizioni contributive.
Le conseguenze pratiche per ricercatori e università
Per i ricercatori e i post-doc, la novità principale è che il lavoro svolto con questi contratti produce piena copertura previdenziale, con versamento dei contributi ai fondi pensione di riferimento e diritto all’assicurazione contro la disoccupazione NASpI.
Per le università e gli enti di ricerca, invece, la circolare comporta la necessità di adeguare i propri sistemi di gestione amministrativa e contabile, per rispettare gli obblighi contributivi e utilizzare correttamente i codici Uniemens.